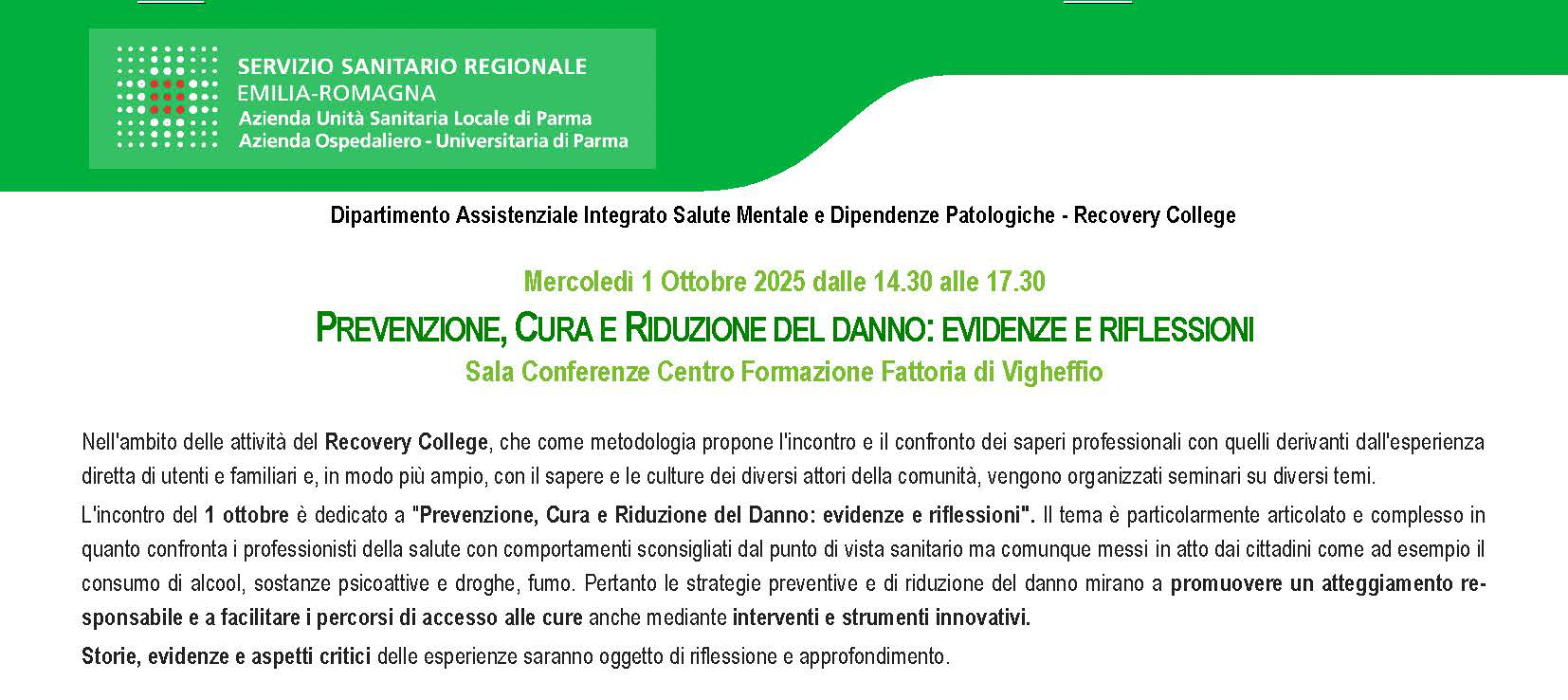
“Dipendenze: prevenzione, cura e riduzione del danno: evidenze e riflessioni”: tra i numerosi esperti a confronto al recente convegno di Vigheffio, nel parmense, è intervenuto anche Roberto Berselli, vice presidente Consorzio Gruppo CEIS. Di seguito, i punti salienti del suo contributo.
“Viviamo in una società in cui il concetto di ‘compatibilità’ – ha sottolineato Berselli – è diventato un criterio etico implicito per valutare le condotte individuali: se un comportamento non disturba apertamente la produttività, le relazioni sociali o la performance lavorativa, allora è considerato tollerabile, a volte persino legittimo. Questa logica, apparentemente pragmatica, diventa pericolosa quando si applica al consumo di sostanze e ai comportamenti di dipendenza… Si normalizzano così comportamenti additivi purché compatibili con una vita ordinata, professionale, persino di successo. Questa è la ‘cultura della compatibilità’: non importa se ciò che facciamo a noi stessi ha conseguenze a lungo termine, l’importante è che non si veda, che non ostacoli l’efficienza, che non dia fastidio”.
Il rischio, dunque, è che la dipendenza diventi questione di gestione funzionale e non più un problema di salute o di senso… Si dimentica così che la dipendenza non è solo un disturbo funzionale, ma una sofferenza esistenziale: un modo per colmare vuoti, per regolare emozioni, per evadere da una realtà percepita come insostenibile. La sostanza o il comportamento additivo diventano strumenti di compensazione in una società che, paradossalmente, li legittima finché restano invisibili.
“La cultura della compatibilità – ha poi proseguito Berselli – si fonda su un’illusione: ciò che non disturba l’ordine sociale appare innocuo. Il mito della “compatibilità” crea un velo di Maya che ritarda il riconoscimento del problema. In realtà, la dipendenza è un processo lento e corrosivo che logora salute, relazioni e capacità di provare benessere autentico. Il pericolo è la dissociazione tra ciò che si vive dentro e ciò che si mostra fuori, che alimenta solitudine, alienazione e dipendenza più profonda. Questa visione deresponsabilizza la società, riducendo la dipendenza a scelta privata, senza interrogarsi sulle cause collettive: ritmi di vita, modelli relazionali, valori dominanti”.
“Dobbiamo invece recuperare una lettura più umana, più complessa, più critica. Serve riconoscere che la dipendenza oltre ad essere una malattia – spesso associata ad altre malattie o condizioni di sofferenza fisica o psichica – è un sintomo, ma non un comportamento da correggere tout-court. Un sintomo di una società che spesso esige prestazioni ma offre poco ascolto; che propone libertà ma rimuove i limiti; che celebra l’autonomia ma disconosce il bisogno. In Emilia-Romagna, l’approccio integrato tra cura e riduzione del danno è patrimonio consolidato: non sono in contrapposizione, ma strumenti complementari di ‘prendersi cura’ e di ‘farsi prossimo’. Tornare alle polemiche degli anni Ottanta sarebbe solo un arretramento”.
Le sfide, allora, sono almeno tre: 1) Culturale: smettere di considerare accettabile tutto ciò che è ‘funzionale’ e cominciare a chiederci che tipo di vita vogliamo davvero vivere, al di là della sola performance. 2) Educativa: formare persone in grado di leggere i propri bisogni profondi, riconoscere i propri limiti e costruire relazioni autentiche, non sostituibili da sostanze o dipendenze tecnologiche. Politica e sociale: creare spazi e tempi di vita più umani, in cui la vulnerabilità non sia una colpa, ma una condizione da accogliere, da condividere, da accompagnare.
“La sfida che abbiamo di fronte – ha concluso Berselli – è quella di creare una cultura che non glorifichi il mascheramento del disagio, ma che lo riconosca, lo affronti, lo accompagni e ove possibile lo trasformi. Una cultura che non accetta la “compatibilità” come metro di misura del successo, ma che valorizza il benessere e la pienezza della vita in tutte le sue sfaccettature”.


